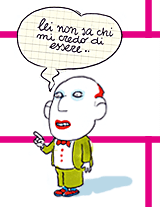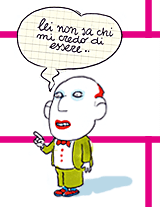|

Fidel, patria y muerte
di Vincenzo Sparagna - 1-12-2016
Ricordo un 26 luglio, festa nazionale cubana, in Plaza de la Revoluciòn all'Avana, era il 1974. Sin dalle prime luci dell'alba cortei e gruppi sparsi di giovani, donne, famiglie con bambini affluivano sul selciato vasto quanto una pianura. Su banchetti improvvisati si vendevano bibite e panini. Si celebrava, come ogni anno, l'assalto alla caserma Moncada di Santiago del 1953 guidato da Fidel, primo atto della rivoluzione che appena sei anni dopo, avrebbe cacciato il dittatore Batista. I discorsi dal palco cominciarono dopo mezzogiorno, la folla era già un oceano impressionante di fazzoletti e di bandiere. Parlarono per primi due membri del comitato centrale del Partito Comunista, discorsi retorici e burocratici, cui fecero eco deboli applausi rituali. Poi alla tribuna salì Fidel, accolto da un'ovazione travolgente. Dialogò con la moltitudine per quasi due ore su toni alti e appassionati non da capo di una piccola isola accerchiata, ma come un rivoluzionario irriducibile il cui orizzonte era l'America Latina e il mondo intero. Ricordò il martirio del Che, l'eroismo di Allende ucciso un anno prima, l'Africa in rivolta contro il colonialismo. Cuba nella sua visione era il centro di un progetto planetario di cambiamento. Mi trovavo in quella piazza come membro della "Brigata Internazionale di lavoro volontario Josè Martì", 300 giovani venuti da tutto il mondo per costruire strade e villaggi. Non c'ero andato seguendo il mito un po' salottiero della revoluciòn esotica, ma per scoprire dal vivo se la via caraibica fosse davvero diversa, come dicevano alcuni, da quella sovietica, che consideravo solo un feroce capitalismo di stato senza futuro. Non lo era. In quei mesi avevo visto con tristezza che il regime, pur realizzando opere straordinarie nell'istruzione e nell'assistenza sanitaria, era ormai divenuto una semplice variante povera del modello russo. Le librerie erano piene di edizioni in lingue estere di Mosca, il partito predicava il cosiddetto marxismo-leninismo di staliniana memoria, la censura imperava e il governo non si faceva scrupolo di perseguitare duramente i suoi oppositori di destra o di sinistra. Io stesso, per aver criticato in pubbliche assemblee le sciocchezze teoriche ufficiali, ero stato definito dai funzionari che seguivano le attività del nostro campo un "malo brigatista". Eppure sentendo parlare Fidel capii perché era così amato e perfino venerato. Quell'avvocato bianco, pur tra mille contraddizioni, aveva trasformato un popolo di ex schiavi neri in una nazione, donando loro l'orgoglio di avere finalmente una vera patria. Dunque, anche senza rendersene conto, sono suoi figli non solo i milioni di cubani che fanno ala piangendo al suo feretro in lenta marcia verso Santiago, ma anche i poveri balseros fuggiti negli anni più difficili a Miami e che oggi festeggiano scioccamente la sua morte. Per questo "a pesar de todo" la storia, come disse lui stesso, lo assolverà.
[ Archivio Editoriali ]
|