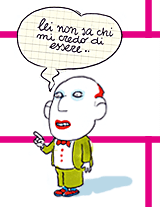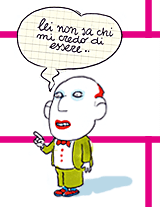|
 Lavora e civiltà Lavora e civiltà
di Vincenzo Sparagna - 18-11-2014
Il mondo è afflitto da drammi giganteschi: fame, malattie, guerre, crudeli fanatismi religiosi, il riscaldamento globale e le sue catastrofiche conseguenze sul clima, la scomparsa di migliaia di specie viventi, l’avvelenamento delle acque e dell’aria. Eppure in Italia si discute solo di economia e soprattutto di lavoro, lavoro e ancora lavoro. Siamo bombardati da talk show dove i soliti noti si azzuffano: chi per condannare l’art.18, chi per salvarlo, chi per chiedere più flessibilità, chi per riaffermare il diritto a non essere ingiustamente licenziati.
Naturalmente, in linea di principio, i difensori dell’art.18 hanno ragione, visto che un licenziamento ingiustificato è per definizione ingiustificato. Eppure l’impressione è che dietro questo straparlare di lavoro si nasconda un vuoto spaventoso. Infatti di che lavoro stiamo parlando? La parola è ambigua. Nessun lavoro esiste fuori delle condizioni sociali date. Vi sono solo lavori concreti che possono essere utili o dannosi, liberi o servili. Ora la ragione per cui milioni di persone sono senza lavoro è che nella società capitalistica il lavoro è una semplice funzione del capitale ed esiste solo quando il capitale dà profitto. Per questo ripetere semplicemente che il lavoro è necessario e dà dignità non serve a nulla, anzi è una ipocrisia bella e buona. Nasconde la triste verità che lavora solo chi produce profitto per il capitale. Non a caso tutti affermano concordi che per far aumentare l’occupazione in Italia servono più investimenti. Ma nessuno ricorda che perché ci siano bisogna che essi “rendano” un profitto maggiore di quanto “rende” la speculazione finanziaria, o investimenti in altri luoghi del mondo. Un circolo vizioso che non può essere spezzato neppure dai mitici investimenti statali che in primo luogo non possono essere fatti - per legge - in concorrenza con i privati, ma in più devono essere attribuiti con bandi pubblici (e imbrogli privati), cui concorrono imprese che vogliono anch’esse fare profitti. Ed ecco il paradosso: ci sarebbero da fare milioni di cose, ma non si possono fare anche se milioni di persone sono disoccupate. Non si lavora per mettere in sicurezza gli argini di un fiume, si mettono in sicurezza (magari imbrogliando sul cemento) gli argini solo se qualcuno ci guadagna. La società non si fonda sulla solidarietà, ma sul profitto privato. Per questo non serve a nulla chiedere nuovi investimenti e lavoro se non si capovolge completamente il punto di vista e la logica economica dominante. Prima di lamentarsi della crisi che fa scomparire o sposta in altre zone del mondo interi settori industriali bisognerebbe chiedersi cosa stiamo producendo e perché. Ma questo è impensabile per sindacati che ragionano in termini semplicemente sindacali e per ex partiti di sinistra asserviti all’ideologia dello sviluppo, ovvero dell’accumulazione infinita di profitto. Bisogna farlo capire a tutti: la mancanza di lavoro non dipende dalla falsa alternativa tra austerità e crescita, non è un problema di “politica industriale” o di “investimenti”, ma di civiltà. Serve una rivoluzione morale e culturale che rimetta al centro la felicità umana, l’utilità delle cose e non l’utile immediato, che sia il perverso profitto o l’innocente salario schiavo di quel profitto. Il resto sono solo chiacchiere da talk show e lotte generose, ma subalterne. Nuotare controcorrente non è facile, ma è l’unica possibilità per non essere travolti dal fango di una società in agonia.
Vignetta di Malù, pubblicata su IL NUOVO MALE n.13 (marzo-aprile 2013).
[ Archivio Editoriali ]
|